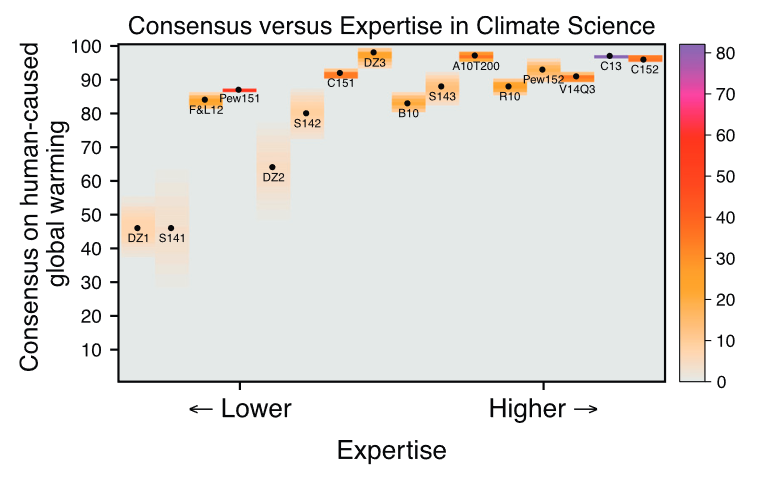Abbiamo viaggiato per l’Italia sconvolta dai fenomeni meteorologi estremi e colpita dai cambiamenti climatici. Un Grand Tour tra grandi città e vigneti, dalla laguna di Venezia all’Emilia Romagna dell’alluvione, con esperti, scienziati, contadini e ragazzi che immaginano il loro domani in mondo incerto. Una guida indispensabile a chi nega il cambiamento climatico per scoprire il futuro che ci aspetta, davvero.
A cura di Simone Giancristofaro
Di Simone Giancristofaro e Valerio Renzi
Alluvioni, incendi, siccità, ondate di calore. I fenomeni meteorologici estremi sono diventati la norma. È l’effetto del cambiamento climatico il cui impatto ormai ha traghettato la nostra vita in una nuova, precaria, normalità. Da luglio a fine agosto abbiamo girato l’Italia, incontrando agricoltori, ricercatori, divulgatori scientifici, ragazzi e ragazze il cui territorio è stato sconvolto dall’alluvione. Per anni si è discusso se vivessimo davvero nell’Antropocene, se gli esseri umani fossero o meno diventati una forza geologica. Quando il termine era già diventato di moda per le scienze umane, le scienze naturali hanno seriamente messo all’ordine del giorno il problema, prendendosi i loro tempi. Dal 2009 l’Anthropocene Working Group, sotto commissione dell’International Commission on Stratigraphy dell’Unione internazionale delle Scienze Geologiche, cerca una risposta in sedimenti e carotaggi: nel 2024 potrebbe arrivare la sanzione ufficiale per la nuova era geologica. Ma intanto che attendiamo l’ufficialità, non ci sono però dubbi sul fatto che l’impatto delle attività umane sia la causa del riscaldamento globale. Su questo convengono il 99,9% degli scienziati. “Il caldo che sentiamo adesso è in parte anche l’effetto del carbone bruciato ai tempi di Charles Dickens”, ci spiega Luca Mercalli quando lo andiamo a trovare in Alta Val di Susa partendo da Milano in cerca di refrigerio. Ma anche qui fa caldo, troppo caldo per le medie stagionali registrare finora: quando guardiamo il termometro fanno 28° e siamo oltre 1600 metri d’altitudine.
Ci muoviamo per la casa del meteorologo e divulgatore scientifico, una delle voci più lucide sul tema in Italia, e ci spiega che lui “la transizione energetica” a casa sua già l’ha fatta, tra pannelli solari e auto elettriche parcheggiate in carica in giardino. “Io penso che la proposta dell’Accordo di Parigi, di rimanere entro 1,5° entro la fine del secolo, sia persa perché non stiamo facendo niente, ma siamo già in ritardo per rimanere sotto i 2°. Ci dovrebbe essere una tale tensione nella società… altro che negazionismo!”. Sì, perché mentre noi giriamo per l’Italia per documentare gli effetti dell’innalzamento delle temperature, il dibattito pubblico è polarizzato tra chi scende in strada a manifestare e chi mette in dubbio che sia davvero un problema. “D’estate fa caldo, d’inverno fa freddo”, sintetizza il ministro Matteo Salvini. Ma nonostante la scienza non abbia dubbi, e nonostante quello che stiamo vivendo, anche il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, nel mezzo dell’estate, decide di dare il suo contributo in televisione, affermando di non sapere se il cambiamento climatico è di origine antropogenica oppure no: “Non so quanto sia dovuto all’uomo quanto sia dovuto al cambiamento climatico… terrestre… perché leggevo ieri sera, il cambiamento climatico è iniziato alla metà del secolo scorso. Chiaro che il secolo scorso ha una caratteristica, quella di essere chiamato il secolo breve, il secolo che ha scaricato di più come emissione… È quello? Non è quello? Io non lo so, però so che c’è”.
Incredibile ma vero. D’altronde il governo di Giorgia Meloni non è proprio il fan numero uno della transizione ecologica, bollata per lo più, tra discorsi sulla “follia green” e il continuo ribadire che le richieste di diminuire drasticamente le emissioni è una questione ideologica. Chi non ha dubbi è invece il Segretario Generale delle Nazioni Antònio Guterres che tuona presentando i dati del luglio 2023 come il mese più caldo mai registrato:
Le conseguenze sono evidenti e sono tragiche: bambini travolti dalle piogge monsoniche; famiglie in fuga dalle fiamme; lavoratori che crollano nel caldo torrido. Per vaste parti del Nord America, dell’Asia, dell’Africa e dell’Europa, è un’estate crudele. Per l’intero pianeta, è un disastro. E per gli scienziati è inequivocabile: la colpa è degli esseri umani. Tutto questo è del tutto coerente con previsioni e avvertimenti ripetuti. L’unica sorpresa è la velocità del cambiamento. Il cambiamento climatico è qui. E’ terrificante. Ed è solo l’inizio. L’era del riscaldamento globale è finita; l’era dell’ebollizione globale è arrivata. L’aria è irrespirabile. Il caldo è insopportabile. E il livello dei profitti dei combustibili fossili e dell’inerzia climatica è inaccettabile. I leader devono fare i leder. Niente più esitazioni. Niente più scuse. Non dovete più aspettare che gli altri si muovano per primi. Semplicemente, per questo non c’è più tempo”
Un messaggio che non lascia spazio a interpretazioni. Così mentre viaggiamo verso Venezia, lo facciamo con ancora nelle orecchie le parole di Mercalli: “L’Italia rischia più di altri paesi, Venezia così è già spacciata”. Arriviamo in laguna, e la navighiamo con i ricercatori dell’Istituto di Scienze Marine del Cnr. Secondo la Banca Mondiale a causa dei cambiamenti climatici 216 milioni di persone dovranno abbandonare la propria terra, i migranti climatici: una catastrofe umanitaria senza precedenti. In Italia sicuramente dovremmo decidere se salvare Venezia o l’ecosistema lagunare. “Intanto il Mose ci fa guadagnare tempo”, nella speranza che si trovino altre soluzioni per salvare la città. Ma più le paratie sono alzate, più lo scambio di acqua dolce e salata si interrompe e il delicato ecosistema lagunare muore.
Venezia che finisce sotto l’acqua è un’immagine classica da disaster movie americano. Ma se la città dei Dogi è in pericolo, lo è anche il patrimonio materiale e immateriale del nostro paese, quello che rende il paesaggio e la cultura italiana così varia e ricca. Per proteggere il made in Italy non basta fare più controlli sulle etichette, ma bisogna combattere i cambiamenti climatici. Il paesaggio delle Langhe è patrimonio dell’Unesco, mentre i suoi vini rappresentano il prodotto più significativo di un distretto produttivo ricco e conosciuto in tutto il mondo. Ma il riscaldamento globale rischia di cambiare tutto. Per sempre.
Così Roberto Cerrato, direttore del sito Unesco Langhe Roero e Monferrato, spiega il programma di monitoraggio dei cambiamenti climatici: “L’altr’anno la produzione è stata del 25 per cento in meno per la siccità. Alcuni produttori hanno acquistato terreni per produrre anche in altezza, ma ci sono solo certe tipologie di vitigno che possono andare su. Questa zona non è sempre stata così ricca, fine 1800 metà 1900, qua non si riusciva a mettere il pranzo con la cena”. Poi ci mostra i sensori piazzati tra i filari d’uva: “Qui c’è un sensore che monitora l’umidità del terreno, questo invece ci aiuta a raccogliere una serie di parametri che ci danno indicazioni insieme all’accrescimento fogliare di quanto il cambiamento climatico abbia delle conseguenze”. Ve lo immaginate il vino delle Langhe prodotto in Germania o in Danimarca e il Marsala in Piemonte? Questo scenario non è poi così lontano.
Nel nostro viaggio, tra città che affondano e agricoltori che provano a capire il loro futuro, abbiamo deciso di tornare anche nelle zone colpite dall’alluvione in Emilia Romagna dello scorso maggio: 21 fiumi esondati, 15 vittime, migliaia di sfollati e miliardi di danni. Più precisamente siamo tornati Forlì, dove ci siamo dati appuntamento con i ragazzi di una web radio che hanno girato per i comuni alluvionati a bordo di un’Apecar. Prima hanno spalato il fango poi, superata la fase dell’emergenza più acuta, hanno raccolto i sentimenti e le storie dei loro coetanei alluvionati.
L’Apecar era già stata testata, viaggiando anche a biometano dalla provincia di Bologna fino a Stoccolma per incontrare Greta Thunberg. “Diciamo che a diciott’anni ne ho già viste troppe per i miei gusti di fenomeni naturali disastrosi. Una volta che hai passato sulla tua pelle una cosa del genere ti rendi conto di quello che può fare la natura. Io sono sempre stato un’ottimista, quindi dico che il futuro sarà diverso il futuro sarà migliore”, racconta Matilde Montanari studentessa di Forlì, che di una cosa però è convinta: per un futuro migliore dobbiamo capire da dove vengono i guai del nostro presente. “Ci siamo resi conto di una cosa, che pochissimi ci hanno detto che l’alluvione è stato causato del cambiamento climatico e questa è una cosa che ci ha fatto un po’ pensare”, spiega. In molti qua sono ancora traumatizzati, preferiscono guardare avanti e basta invece di cercare soluzioni al futuro, ma quelli di Radioimmaginaria preferiscono guardare il bicchiere mezzo pieno raccogliendo voci, storie, proposte: “Parlarne con persone che hanno visto i loro ricordi sparire in mezzo al fango proprio ti si spezza il cuore in mille parti, si vede proprio negli occhi delle persone questo dolore immenso. Sì, l’alluvione ha distrutto tutto però ha creato un senso di comunità che prima non avevamo”. E magari è qualcosa da tenersi stretto per ricominciare.
Il nostro viaggio termina a Milano dove era iniziato. Il capoluogo lombardo funestato quest’estate da una tempesta che ha abbattuto centinaia di alberi, dove la colonnina di mercurio è salito a segnare nuovi record (come in grandi altre città italiane) e dove abbiamo cercato risposte a come si possono mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici. L’ultima voce che abbiamo ascoltato è stata quella di Fabio Deotto, che settimanalmente ci accompagna su Fanpage.it per parlare proprio di cambiamento climatico. A lui abbiamo chiesto cosa aspettarci dal futuro. Vi lasciamo con le sue parole: “L’estate è passata da essere una stagione di gioia e di relax, a essere una stagione che fa paura. Ci sarà un aumento sempre maggiore di carestie, siccità, eventi estremi. Qualunque settore della nostra esistenza verrà toccato in maniera negativa dal riscaldamento globale. Allo stesso tempo immagino un futuro in cui quelle misure sono state adottate in modo drastico, in cui abbiamo cambiato sistema economico e produttivo. In cui abbiamo cambiato anche la nostra cultura del consumo, dell’accumulo e della crescita. E se mi chiedi come sarà vivere in un mondo del genere, io mi immagino una vita migliore di quella che stiamo vivendo adesso. È questa, credo, la cosa più importante”.